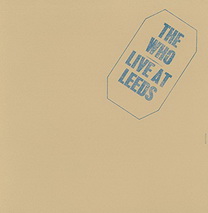Alfredo Marziano
13 mar 2012 - Eravamo venuti a teatro per rendere omaggio a “Tommy”, più o meno come si fa quando si va a vedere l’ “Aida” o il “Rigoletto”. Ma poi ci siamo scaldati, divertiti, entusiasmati con la seconda parte dello show, tra imprevisti e cambi di scaletta: la svolta arriva alle ultime battute della rock opera, con il canto liberatorio di “We’re not gonna take it/See me, feel me/Listening to you” che ai numerosi over 50 in sala evoca epiche immagini di Woodstock e di un cantante riccioluto con la giacca a frange. E’ in quel momento che il pubblico torinese, fino ad allora compito e composto come da copione, si alza in piedi e si butta verso il palco con buona pace di chi ha pagato salata la sua poltrona da prima fila. E’ lì che termina la rappresentazione e comincia il rock’n’roll. Roger Daltrey è un uomo onesto che dice pane al pane e spiega come stanno le cose. Questi non sono gli Who (“non ha senso far finta che sia così, senza Pete”), lui se ne frega dei confronti ed è qui per divertirsi. E’ così sincero da ammettere che cantare due sere di fila, ora che non è più un ragazzino, non fa bene alla sua voce (il giorno prima si era esibito a Genova). Ce n’eravamo accorti, a tratti, durante l’esecuzione di “Tommy” riproposto per intero: i suoi ruggiti leonini qualche volta restano a mezz’aria e anche la band sembra un po’ intimidita, ingabbiata dai rigidi confini della partitura. Il colpo d’occhio, all’entrata al Teatro Colosseo, era invitante: un’atmosfera intima e un palco vintage, da anni Settanta, con la batteria schermata da pannelli di plexiglas e uno schermo che durante l’esecuzione proietta immagini in realtà poco influenti sul valore dello show. Quando arrivano le note familiari dell’ “Overture” Roger, in camicia, pantaloni scuri e occhialini tondi, si presenta subito a centro palco percuotendo due tamburelli. Ma è nel roteare il microfono come un lazo che è ancora un vero maestro, un acrobata spericolato: “Amazing journey” serve a ricordarcelo e a strappare applausi convinti. Alla sua destra, sul palco, t-shirt col simbolo dei Mod e zuccotto in testa, c’è un altro tipo dal timbro vocale e l’aspetto vagamente familiare. E’ Simon Townshend, fratello minore di Pete venuto qui a fare le sue veci come voce di controcanto e chitarrista, mentre all’altro lato il solista e direttore musicale Frank Simes, cappello e maglietta col marchio Ferrari, tira fuori le unghie poco alla volta. In seconda linea un bassista in camicia a quadri e l’aspetto del ragazzino, Jon Button, un discreto tastierista dai capelli lunghi, Loren Gold, e un bravissimo batterista vecchio stampo, Scott Deavours, puntualissimo nelle rullate e negli stacchi. “Sparks” offre a Button l’occasione di esibirsi in qualche bella scala di basso, e nell’hard blues di “Eyesight to the blind” la voce di Roger comincia finalmente a uscirgli di gola aggredendoci come ai bei tempi. Sotto le sembianze del musical e del cabaret, “Cousin Kevin” e “Fiddle about” sono roba tosta che affronta temi di scottante attualità (il bullismo e gli abusi sessuali sui minori), la psichedelica “Acid queen” è affidata alla voce di Simon e il microfono torna a roteare nella leggendaria “Pinball wizard” (l’applauso, qui, scatta come un riflesso pavloviano). E’ un riff scolpito nella roccia come quello di “I’m free”, mentre “Tommy can you hear me” e la amara parabola di “Sally Simpson” si colorano di country rock, con una coda di piano blues e chitarra flamenco. Tutto bello: eppure manca qualcosa, fino a quando il pubblico non si alza in piedi, Roger imbraccia la chitarra acustica, la band scioglie i muscoli e si libera della tensione. E’ un altro concerto, a partire da “I can see for miles”, anche se dopo “The kids are alright” la Rickenbacker dodici corde non ne vuol più sapere di restare accordata (“ecco perché la suonavamo poco, nei Who”) e Daltrey, dopo avere ingollato secchiate d’acqua ed essersi lamentato per il caldo, chiama un time out e cede la scena a Townshend jr. per “The way it is”, bella melodia pop che il pubblico mostra di apprezzare. Prima ci aveva regalato una bellissima “Behind blue eyes” con una preziosa armonia a tre voci; poi, dopo un affettuoso ricordo della sua adolescenza operaia e dei suoi weekend di baldoria (“Days of light”), rivolge una dedica al popolo greco in rivolta contro il “Big Man” sulle note della melodia irlandese di “Gimme a stone” ripescata da un vecchio progetto degli Hooters con Garth Hudson e Levon Helm (Largo). “Who are you” risveglierebbe anche i morti, anche perché Simes e Townshend, lì davanti, sono ormai padroni del palco e sembrano divertirsi un mondo. E pure gli arrangiamenti, in questa seconda parte, riservano belle sorprese: “My generation” in versione blues lento e in medley con la “Mannish boy” di Muddy Waters, crea un’atmosfera da club inglese ai tempi del blues revival primi Sessanta, e “Young man blues” è da antologia. “Oggi sono i vecchi ad avere in mano tutto il denaro/mentre i giovani non hanno nulla in questo mondo” sembrano parole scritte oggi, lo standard di Mose Allison (e degli Who) è potente e catartico con Deavours perfetto negli stop e ripartenze e Roger che chiosa con un sonoro “fuck off” da vecchio working class hero incazzato. Quando arriva “Baba O’ Riley” sono scoccate le due ore, Daltrey soffia forte nell’armonica, si sbottona la camicia e la platea è definitivamente conquistata. E’ al pubblico che il frontman dedica il pezzo finale “Without your love”, il suo maggior successo da solista che chiude il programma su toni quieti e sentimentali. E’ tempo dei saluti, “be happy, be healthy and lucky”. Grazie Roger, ma tu intanto copriti e riposati che hai ancora tante canzoni da cantare.